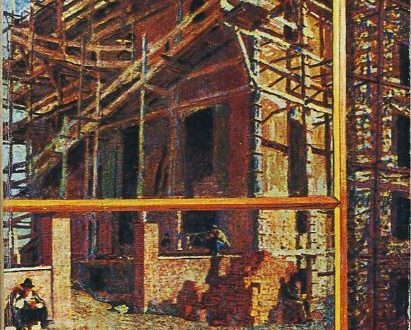La fedeltà in alcuni romanzi italiani del Novecento
I Malavoglia, il romanzo più noto di Giovanni Verga è la celebrazione della casa e della fedeltà a tutti quei valori che intorno ad essa gravitano: onestà, fedeltà, affetti semplici e forti. E nel quadro di questa fedeltà alla casa, anche l’amore viene sacrificato. Nell’amore di compare Alfio per Mena Malavoglia c’è una tristezza indicibile. Essa paga personalmente per le colpe di tutti. La casa del Nespolo sarà riscattata dal più piccolo dei Malavoglia: Alessi. Ma essa non è mai il rifugio tranquillo dove si consumano i miti del benessere, ma il piccolo monticello bruno a cui tornano ad aggrapparsi le formiche dopo lo spasimo ed il via vai della disperazione e della tempesta. E in questa riconsacrazione della casa non ci sarà più posto per coloro che se ne sono allontanati: Lia e ’Ntoni. L’addio di ’Ntoni di padron ’Ntoni da tutto un mondo di affetti e di legami semplici che lui aveva avuto prima della ribellione alla miseria, è straziante. Quando ritorna dal carcere, Alessi, il più piccolo dei Malavoglia lo invita a restare. ’Ntoni non se la sente di rimanere. Lui che aveva avuto il coraggio di dare una coltellata a don Michele, la guardia del paese e di cacciarsi nei guai, risponde così all’invito del fratello: “No! – rispose ‘Ntoni. – Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? E la Nunziata che spiegava gli indovinelli? E la mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene”. In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. “Addio, – ripeté ’Ntoni. – Vedi che avevo ragione d’andarmene! Qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti”.
In Metello, il romanzo più conosciuto di Vasco Pratolini, la dignità di Ersilia nel subire il tradimento del marito Metello con la bella Idina, così traspare in tutta la sua grandezza: “Si imparano mille cose in un istante, non occorre essere stati a scuola, quando la vita ti colpisce a tradimento con le sue cattiverie: basta avere una spina dorsale che ti mantenga in piedi. Ersilia ne faceva in quel momento una dolorosa esperienza. La sua lealtà, il suo coraggio, la sua abitudine ad affrontare a viso aperto le ingiustizie ed i dolori che non le erano stati risparmiati, alla resa dei conti l’avevano sempre trovata vincitrice, o comunque preparata a subirne l’irreparabilità. Se questo mondo è una giungla, ella era nata e vissuta in quella giungla, particolarmente intricata ch’era San Frediano; nondimeno, c’era questa sua naturale solarità, questa oasi e questa radura del cuore che ogni volta la illuminavano e le permettevano lo scampo. La stessa disgrazia che le aveva rapito il padre, ad esempio, e che aveva rappresentato la congiuntura più sofferta e drammatica della sua vita, aveva favorito il suo incontro con Metello. L’eterna forza dei semplici, di affidarsi e nello stesso tempo di non arrendersi al proprio destino. “Male non fare, paura non avere”. La sua fiducia nella vita, infine, aveva sempre trovato un esatto rapporto nella spontaneità, nella chiarezza diciamo e nella costanza dei suoi sentimenti e dei suoi affetti. Ora per la prima volta era stata colpita alle spalle; e non per questo era crollata. Ma la sorpresa le aveva inibito una subitanea ribellione, lo stupore aveva sopraffatto l’offesa. Forse da questa esperienza ne sarebbe uscita più amorosa, più comprensiva, più saggia ma definitivamente disincantata, meno franca, meno spontanea e cordiale. Questo avvenimento, che d’ora in avanti l’avrebbe costretta a diffidare del proprio istinto, a cautelarsi contro l’intrigo, segnava inconsciamente il suo congedo spirituale dalla giovinezza. Già le era bastato un istante per possedere compitamente l’arte della dissimulazione, questo ripugnante magistero a cui gli uomini sembrano avere affidato l’equilibrio del loro rapporti”.
Nel libro La Luna e i falò, uno dei romanzi più belli di Cesare Pavese, Anguilla, il trovatello delle Langhe, ritornato nel proprio paese di origine, dopo esserne stato lontano per tanti anni, così canta la fedeltà al mondo e agli ambienti che aveva visto fin da piccolo: “Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestra vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull’aia. Capii lì per lì cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci sepolto insieme ai vecchi, intanto adesso mi faceva l’effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti”.
Canelli era per il protagonista la porta del mondo perché vi passava la ferrovia, la stessa che aveva preso tanti anni prima: “Il fischio del treno che sera e mattina correva lungo il Belbo facendomi pensare a meraviglie, alle stazioni, alle città. Così questo paese dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto.
Un paese ci vuole, non fosse per il gusto d’andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.
Il paesaggio dell’infanzia e della prima adolescenza ritorna prepotente nei ricordi di Anguilla: “Io sono scemo, dicevo, da vent’anni me ne sto via e questi paesi mi aspettano. Mi ricordai la delusione ch’era stata camminare per la prima volta per le strade di Genova – ci camminavo nel mezzo e cercavo un po’ d’erba. C’era il porto, questo sì, c’erano le facce delle ragazze, c’erano i negozi e le banche, ma un canneto, un odor di fascina, un pezzo di vigna, dov’erano? Anche la storia della luna e dei falò la sapevo. Soltanto, m’ero accorto, che non sapevo più di saperla”.
Così Anguilla ricorda gli anni trascorsi alla Mora come garzone, dopo essere andato via da Gaminella: “Il bello di quei tempi era che tutto si faceva a stagione, e ogni stagione aveva la sua usanza e il suo gioco, secondo i lavori e i raccolti, e la pioggia o il sereno. L’inverno si rientrava in cucina con gli zoccoli pesanti di terra, le mani scorticate e la spalla rotta dall’aratro, ma poi, voltate quelle stoppie, era finita e cadeva la neve. Si passavano tante ore a mangiar castagne, a vegliare, a girare nelle stalle, che sembrava sempre domenica.
Mi ricordo l’ultimo giorno dell’inverno e il primo dopo la merla, quei mucchi neri, bagnati, di foglie e meligacce che accendevamo e che fumavano nei campi e sapevano già di notte e di veglia, o promettevano per l’indomani il bel tempo. L’inverno era la stagione di Nuto. Adesso ch’era giovanotto e suonava il clarino, d’estate andava per i bricchi o suonava alla stazione, soltanto d’inverno era sempre là intorno, a casa, sua, alla Mora, nei cortili…
Poi veniva la stagione che in mezzo alle albere di Belbo e sui pianori dei bricchi rintronavano fucilate già di buon’ora e Cirino cominciava a dire che aveva visto la lepre scappare in un solco.
Sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare, sfogliare, torchiare non sono neanche lavori, caldo non fa più, freddo non ancora; c’è qualche nuvola chiara, si mangia il coniglio con la polenta e si va per funghi”.
Sono pagine proprie delle Langhe, care a Cesare Paese, ma valgono anche per il nostro mondo contadino di tanto tempo fa.
È importante tenerlo vivo nel ricordo.
C’è chi si vergogna di essere nato in una famiglia contadina.
Io ne vado orgoglioso. •
 La Voce delle Marche Periodico di informazione e cultura della Diocesi di Fermo fondato nel 1892
La Voce delle Marche Periodico di informazione e cultura della Diocesi di Fermo fondato nel 1892